Beppe non parla inglese ovvero il paradosso della lingua franca
“The Power to control the language offers far better prizes than taking away people’s provinces or lands or grinding them down in exploitation. The empires of the future are the empires of the mind”
È il 6 settembre del 1943. Il mondo è nel bel mezzo del secondo conflitto mondiale. Lontano dalle trincee, dagli spari, dalla morte, una platea di studenti e docenti universitari di Harvard ascoltano rapiti dalla potenza delle sue parole il Primo ministro inglese Winston Churchill, in occasione del conferimento della laurea honoris causa.
Con uno zelo magistrale e una dialettica impeccabile, il suo discorso fissa con termini inequivocabili ciò che a posteriori verrà identificato come il manifesto dell’imperialismo linguistico occidentale (o monopolio, se vogliamo declinarlo in tempi recenti), giustificando in un solo colpo secoli di Commonwealth, colonialismo europeo e le successive “crociate” di “democratizzazione” verso il fantomatico Oriente [n.d.r.: ciò che non è Europa].
Il ragionamento alla base è di una semplicità imbarazzante, lo si potrebbe quasi ricondurre a un’equazione di primo grado: egemonia linguistica = egemonia culturale. La capacità di controllare la lingua di un popolo implica controllarne la cultura. E controllarne la cultura implica controllarne la mente. E che si parli di assoggettamento delle colonie o di un lento, inesorabile processo di contaminazione attraverso il tubo catodico, il risultato è identico: il “colonizzato” sarà grato al “colonizzatore” per aver spianato la strada verso la “vera” cultura. Ed è in questo modo che l’imperialismo occidentale ha agito e agisce tuttora, passando il testimone alla sua diretta erede globalizzazione, edulcorata e mascherata nel suo progressismo.
Concluso il primo ventennio del nuovo secolo infatti, l’egemonia rintracciabile nelle parole di Churchill deve essere naturalmente riconfigurata. Termini come “controllo” o “assoggettamento” non sono più ammissibili in una società moderna e democratica. Hanno un fascino retrò, che chiaramente andrebbe a scontrarsi con i dettami del mondo civilizzato. E non bisogna certamente essere uno scienziato per riconoscerne l’inefficacia agli albori del nuovo millennio. Anche Giuseppe (Beppe per gli amici), agricoltore sessantasettenne di San Marzano di San Giuseppe (TA), ci direbbe che si tratta di una barbarie, mentre munge una delle sue ventitré pecore per farne del buon cacioricotta, in una calda giornata di fine maggio.
Ma l’egemonia non scompare con la civilizzazione. Fa un giro immenso, ma poi torna. In questo caso con un asso nella manica: la nozione di lingua franca, ovvero la necessità di una mutua comprensione, una lingua parlata e intesa universalmente. Con uno slancio biblico alla ricerca di una neo-Torre di Babele, in un mondo moderno e civilizzato tutti abbiamo il diritto (o il dovere?) di capirci l’un altro. Ora, mettiamo caso che un impiegato del catasto della periferia di Londra decida di scappare dalla grigia frenesia della City, prendere armi e bagagli e di partire in vacanza. Magari in Italia, verso il sud. Magari proprio a San Marzano, dove con famiglia al completo si ferma al baracchino del nostro Beppe, davanti alle sue forme di cacioricotta decisamente invitanti. Ma la situazione è ostica, l’inglese cockney dell’impiegato è arabo per il povero fattore, che a stento parla in italiano. Si esprime quasi esclusivamente nel suo dialetto, un misto tra salentino e arbëreshë. La trattativa non s’ha da fare. Se Beppe avesse parlato la fantomatica lingua franca, a quest’ora avrebbe venduto un bel po’ del suo cacioricotta all’impiegato londinese che passava di lì. Magari con un buon passaparola avrebbe creato un network, buttato giù un business plan, aumentato gli income. Pazienza, cercherò qualcosa di tipico al primo ipermercato lungo il tragitto, pensa l’impiegato: lì qualcuno che capisce il suo inglese cockney ci sarà. L’esempio è emblematico, mi sembra di sentire la mia prof delle medie: “se non studiate l’inglese, non andrete da nessuna parte!”. Eppure Beppe col tuo trattore va dove gli pare, avrei voluto risponderle.
Ora, non prendetemi come un detrattore della lingua franca, soprattutto se introdotta già durante i primi anni di scolarizzazione. La mutua e reciproca comprensione attraverso una lingua comune è certamente un fattore positivo, il plurilinguismo è da incoraggiare: se Beppe avesse avuto anche solo un B1 d’inglese, magari a quest’ora sarebbe un magnate del cacioricotta, invece dei due spicci che tira su al mercato settimanale.
Tuttavia, il rovescio della medaglia non tarda a palesarsi. Secondo le stime dell’Endangered Languages Project, attualmente sono circa 7.000 le lingue (o idiomi, varietà, dialetti) parlate nel mondo. Di queste, circa 3.000 sono destinate a “scomparire” nel passaggio al prossimo secolo. Le motivazioni sono molteplici, ma l’assioma è uno: lingua forte mangia lingua debole, la lingua dominante ingloba la lingua dominata. In quello che diversi studiosi definiscono come “cannibalismo (o darwinismo) linguistico” è facile ritrovare la causa della graduale scomparsa della diversità e dell’immenso patrimonio che ogni singola lingua (standard o non standard, di prestigio o regionale, di città o di periferia) rappresenta. Ed ecco che si svela ai nostri occhi il paradosso della lingua franca e della moderna globalizzazione, che incoraggia il plurilinguismo, ma poi distingue quello di serie A e da quello di serie Zeta. Se lingua X non facilità la comprensione con la comunità e il graduale inserimento del singolo nella stessa, che senso ha quindi mantenerla o preservarla?
Per salvaguardarne l’identità e, di riflesso, l’insieme. La pluralità di singole identità. Di singole lingue, culture, menti. Una diversità che arricchisce e non disgrega.

E non bisogna essere uno scienziato per riconoscerlo. Lo sapeva bene Churchill, il 6 settembre del ’43, insieme alla platea di studenti e docenti universitari di Harvard. Lo sa bene chi, il 15 dicembre del ’99 fu fautore della 482, ossia la Legge che sancisce le Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Lo sa bene anche chi, dopo vent’anni da quella stessa legge, ha abbandonato buona parte delle comunità ivi elencate per mancanza di fondi, affibbiandone l’onere alle singole autorità locali, molto spesso incapaci o inadatte.
L’unico a non sapere tutte queste cose probabilmente è proprio Giuseppe-detto-Beppe, ma del resto poco gli importa: il monopolio linguistico e la lingua franca non fanno certo cagliare il latte. Ciò che sa per certo è che il suo dialetto è la lingua dei suoi genitori, dei suoi nonni, delle sue radici. L’italiano lo parla poco, perché a scuola non ci andava e a San Marzano lo capivano tutti, quindi non aveva bisogno di impararlo. Tuttavia c’è solo una cosa che Beppe non capisce e la cosa lo disturba molto: avrebbe tanto da raccontare ai suoi nipoti di sei e tredici anni (loro sì, che parlano la lingua franca), di come viveva da piccolo nella casa dei nonni insieme a tutta la sua famiglia fino al cugino di terzo grado, di come prendersi cura delle bestie con cui vive in campagna, delle giuste quantità di latte di pecora e di capra che servono per fare il cacioricotta come gli ha insegnato suo padre e suo nonno prima di lui, parlargli della guerra e della povertà.

Eppure non ci riesce: ogni volta che prova ad aprir bocca, i suoi due nipoti di sei e tredici anni lo guardano allo stesso modo con cui lui, pochi giorni prima, aveva guardato uno strano tipo che veniva da chissà dove e aveva da dire qualcosa sulle sue forme di cacioricotta, chissà cosa poi.

La consapevolezza di una barchetta

Narrarsi in fabbrica
Potrebbe anche piacerti
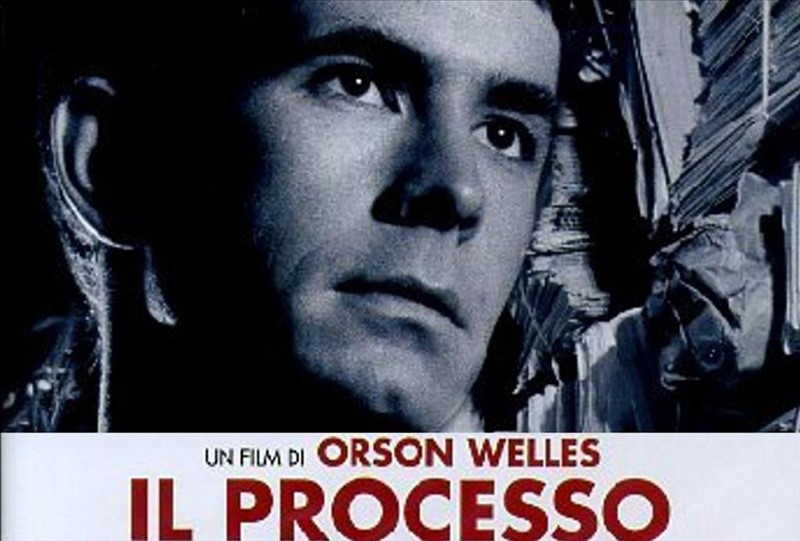
Insetti, occhiali e umorismo: alcune considerazioni su Woody Allen e Franz Kafka
1 Febbraio 2017
L’amante masochista
24 Ottobre 2018
Un commento
Davide
Ottimo contributo, capace di innescare riflessioni a non finire. Non ci pensiamo, per esempio, ma noi siamo la lingua che parliamo: una lingua che non è mai neutra, come la nostra epoca dei corsi di lingua vuole farci credere. La lingua che parliamo rivela chi siamo, e nel contempo forgia giorno dopo giorno la nostra mente e la nostra visione del mondo. Francamente non credo che sia un problema da risolvere, quanto un fenomeno di cui essere ben consapevoli. Inquieta semmai constatare che il tema è stato approfondito notevolmente nella seconda metà del secolo scorso: penso alla neolingua di Orwell in 1984, al Pasolini che distingueva la lingua della comunicazione da quella espressiva (i dialetti), penso al lucido allarme lanciato da Marcuse nel suo Uomo a una dimensione. Da qui bisogna ripartire, secondo me.