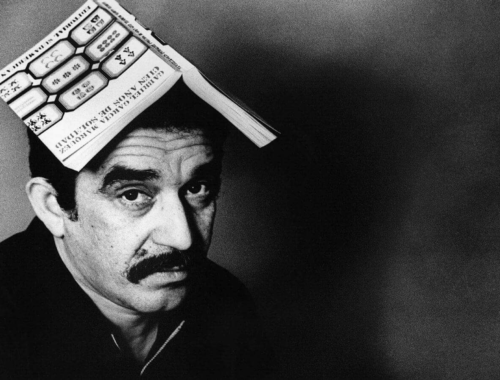Oltre il turismo, oltre la svendita dei gioielli di famiglia al Monte di Pietà

Si sa, l’Italia corre a (almeno) due velocità: l’Italia del Nord – per semplificare – che sotto la spinta della sua tempestiva industrializzazione è ora ben assestata sul fronte agonistico dell’economia digitale, e l’Italia del Sud che arranca tra post-feudalesimo agricolo, colonialismo industriale e turismo.
Se anche volessimo cedere per una volta all’immaginario ideologicamente indotto della gara e degli atleti in lizza (territori avanzati e arretrati, i primi e gli ultimi: il linguaggio dice tutto), dobbiamo comunque riconoscere che la competizione non si è svolta e non si svolge all’insegna dei valori decoubertiniani: prima del via e persino nel vivo della corsa e a bordo pista gli Abebe Bikila affamati e a piedi scalzi sono stati ostacolati in mille modi, niente arene avveniristiche in cui allenarsi per loro, nessun ambiente assistito in cui coltivare e spremere a fondo le loro potenzialità, tutt’al più la proposta allettante di fare da lepre al campione predestinato.
Fuor di metafora, solo a uno sprovveduto può sfuggire oggi che il liberismo economico è intimamente competitivo, che necessariamente al successo di qualcuno deve corrispondere il degrado di qualcun altro; meglio: che il successo di qualcuno non può avere luogo se non sfruttando il potenziale inutilizzato di qualcun altro, come la classica coperta che può scaldare me solo a condizione che lasci al freddo te.
Questa dinamica agonistica – intimamente feroce, e tanto più spietata quanto più deregolamentata – si svolge in qualsiasi ambito sociale, anche minimo, e quindi per noi prima in Italia che nel mondo globalizzato. Si pensi per esempio al fenomeno della delocalizzazione industriale, ovvero dello spostamento della produzione in territori “arretrati” dove il profitto dell’imprenditore può crescere non solo grazie ad accordi salariali al ribasso, ma anche grazie al risparmio sulle spese per la tutela di diritti fondamentali: la salute (sicurezza, malattia, maternità, ferie e turni di riposo etc.) e l’ambiente (manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di filtraggio etc.). Ebbene, non rientrano nell’ambito sempre torbido della delocalizzazione (e quindi del colonialismo economico) i casi delle più importanti realtà industriali del Sud Italia, dall’Italsider e poi Ilva di Taranto, ai poli petrolchimici di Augusta e di Gela, all’Eni di Viggiano? E che dire dello smaltimento di rifiuti industriali pericolosi, lungo la tratta Nord – Sud, sotto fertili campagne coltivate a vigne e uliveti? C’è ancora qualcuno che si scandalizza all’affermazione che i ricchi profitti dell’industria – prima di Stato che privata – sono stati assicurati dallo sfruttamento cinico del capitale umano e territoriale di intere comunità costrette a svendere la propria salute, il proprio ambiente al Monte di Pietà per sopravvivere?
Svendita della salute, svendita dell’ambiente, certo: nella retrospettiva lunga che queste vicende storiche ormai decennali ci consentono la conclusione è indiscutibile. Ma oggi? Sono ancora operative queste dinamiche di sfruttamento perlopiù legale oggi che i temi del diritto alla salute e dell’ambiente svenduto sono sotto la luce incrociata dei riflettori dell’informazione, della politica, della magistratura, delle popolazioni stesse?
A me pare che, come in una malattia sistemica che colpisce con sintomi diversi ora un distretto dell’organismo ora un altro, la stessa logica dello sfruttamento implicita nel liberismo economico possa oggi essere osservata in due nuove forme: la sottrazione ai territori “marginali” dei loro giovani più brillanti (dal punto di vista dell’economicismo imperante) e il turismo inteso in questi stessi territori come settore economico strategico.
Quanto alla prima forma mi limito a confutare preventivamente l’obiezione che i flussi migratori da Sud siano fenomeno antico: oggi però dalle nostre regioni meridionali partono generalmente, spesso in modo definitivo, le intelligenze più ambiziose e più vivaci, con un’evidente deprivazione di risorse culturali, civili e professionali da territori che senza di esse difficilmente potranno realizzare il loro riscatto.
Più temibile trovo infatti la seconda forma, quella del turismo come sfruttamento, perché le persone – si sa – vanno e vengono, i territori invece restano: il loro degrado può incidere sul futuro di intere comunità per generazioni. Ora il turismo, come categoria economico-produttiva, può essere a mio giudizio utilmente analizzato nella controluce dei processi del capitalismo industriale. Come in questo il profitto più significativo viene realizzato spremendo a fondo gli operai e in dispregio dell’ambiente interno ed esterno alla fabbrica (ILVA di Taranto docet), così gli imprenditori del turismo sono necessariamente spinti a concorrere tra loro spremendo a fondo, oltre ai soliti sottoposti, le risorse del paesaggio, ivi includendo le bellezze naturali, storico-culturali ed eno-gastronomiche.
A poco servono i buoni propositi di agire nel rispetto del territorio e delle sue tradizioni: è il modello capitalista e liberista a guidare le danze. Per attrarre più turisti e stare sul mercato, per esempio, è naturale che il proprietario di uno stabilimento balneare cercherà di ottenere in concessione i tratti di costa più belli (e più fragili), così come è naturale che sarà spinto a forzare i limiti della loro tutela per venire incontro alle richieste dei suoi clienti, spingendo magari la piattaforma per una cena galante o per l’irrinunciabile ballo fino a coprire le ultime propaggini della macchia mediterranea. È altrettanto ovvio che, una volta entrati nel vortice di questa mentalità, gli stessi amministratori saranno disposti a chiudere un occhio, magari addirittura convinti (la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni, diceva quel tale) di realizzare così maggiori entrate a beneficio della cittadinanza. L’esempio generico è volutamente edulcorato, perché la realtà è così eccessiva che confonde invece che chiarire: pensiamo all’esempio terribile di Venezia (Salvatore Settis ci ha scritto un libro: Se Venezia muore, Einaudi, 2014), e ora a Gallipoli, la “città bella”, che comincia a rotolare sulla stessa china.
 Una nave da crociera a Venezia.
Una nave da crociera a Venezia.
E quindi? Quindi e paradossalmente proprio i territori “arretrati”, quelli che ancora detengono un capitale umano e paesaggistico solo marginalmente intaccato dal tarlo liberistico globale, possono costituire l’avanguardia di una nuova economia che – a saper guardare lontano – già si affaccia all’orizzonte. Chi è preso nel vortice dell’attuale modello economico crede che il futuro sia tutto nella tecnologia, nell’industria robotizzata, nell’ acciaio e nel cemento come in passato, mentre i beni più preziosi, quelli per cui le nazioni rischieranno o faranno la guerra – dicono a chiare lettere gli esperti di geopolitica – saranno quelli primari: la terra e l’acqua.
Si è presi dallo sconcerto a sentire che il cibo del futuro saranno gli insetti, che i prodotti ortofrutticoli saranno coltivati in spazi chiusi alla luce programmata di particolari neon, quando basterebbe preservare terre vocate all’agricoltura dalla speculazione edilizia, industriale e – appunto – turistica con le loro annesse esigenze di servizi e infrastrutture: strade per esempio, strade sempre più larghe e più veloci, a danno di muretti a secco, di ulivi secolari e di altre bellezze storico-paesaggistiche.
Non turismo quindi, ma agricoltura; meglio: non il turismo come obiettivo primario cui sacrificare paesaggio e tradizioni alla stregua di vili strumenti, ma come eventuale effetto secondario di un’economia centrata sull’agricoltura (naturalmente nelle aree del Paese a ciò predisposte). La prevedibile resistenza a questa prospettiva dipende a mio avviso esclusivamente da un immaginario colonizzato da logiche ancora feudali e baronali, per cui chi lavora la terra è definitivamente il “cafone”, l’ultimo degli ultimi, il lavoratore senza diritti e senza dignità la cui forma odierna più compiuta è quella degli immigrati schiavizzati dai caporali di tutta Italia.
E se invece pensassimo a una riqualificazione della categoria professionale dell’agricoltore, fiscalmente sostenuto o inquadrato con contratti equiparabili a quelli delle altre categorie: salario adeguato, regolamentazione concordata di permessi, ferie, maternità, tutela della salute etc.? È un’utopia? E se immaginiamo che l’intero tessuto sociale, nonché l’amministrazione che lo rappresenta decidano di invertire la rotta, comprendano che essi possiedono una risorsa che a breve diventerà preziosissima e facciano fronte comune per sostenere un progetto di recupero e valorizzazione del lavoro agricolo, l’utopia non si trasforma in un’ipotesi concreta? Il rischio di impresa potrebbe per esempio essere ridotto garantendo una quota di consumo a chilometro zero al produttore, che inoltre stornerebbe a suo favore i profitti altrimenti drenati dalla filiera lunga; d’altra parte il consumatore potrebbe scambiare il suo impegno all’acquisto con il diritto a controllare quantità e qualità di fertilizzanti e fitofarmaci.
L’ovvio presupposto è che la comunità di un territorio “arretrato” acquisisca la consapevolezza che il modello dominante la condanna a una lenta agonia e che essa può, invece, gettare le basi per un modello alternativo che le consentirebbe di conseguire molti vantaggi in un colpo solo: economia e tutela paesaggistica non sarebbero più alternativi, ma proprio la cura del territorio genererebbe lavoro (dignitoso e qualificato, quindi appetibile) e gettito fiscale, salute (la famosa dieta mediterranea al netto dei contaminanti industriali), identità e rispetto della propria storia, nonché un “turismo” secondario che non avrebbe più il potere di piegare uomini, tradizioni e paesaggio a proprio uso e consumo.
Il primo passo sarebbe dunque quello di porre la questione e di avviare una approfondita riflessione pubblica, sulla scorta magari delle sempre più numerose esperienze di giovani che in tutta Italia hanno scelto di precorrere i tempi e hanno avviato imprese agricole del tutto emancipate dal cliché del “cafone” con la zappa: sono spesso laureati, integrano tradizione e sapienza scientifico-tecnologica, dialogano con comunità e amministrazioni illuminate.
Siamo tutti! Siamo tutti e tutte! Siamo tutt*!
Potrebbe anche piacerti

L’amante masochista
24 Ottobre 2018
Il cielo che (non) vediamo
31 Luglio 2017